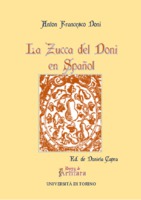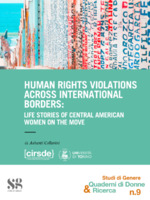Sfoglia documenti (217 in totale)
La Zucca del Doni en Spañol
Human rights violations across international borders: life stories of Central American women on the move
Professioni non togate nel Piemonte d'Antico Regime : professionisti della salute e della proprietà
Il pubblico concorso come funzione amministrativa
Il sistema dei rimedi post-iudicatum in adeguamento alle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo
Ormai da tempo il principio di intangibilità del giudicato penale è oggetto di un inarrestabile “processo erosivo”, tra l’altro per via dei riflessi, nell’ordinamento interno, della normativa internazionale a tutela dei diritti umani. Il riferimento va, in particolare, all’obbligo, per ciascuno Stato membro del Consiglio d’Europa, di dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che riscontrino una violazione, ad opera di quello Stato, delle garanzie convenzionali: considerato, infatti, che la Corte europea può essere adita solo previo esaurimento delle vie di ricorso interne, l’adozione delle misure, diverse da una mera riparazione pecuniaria, prescritte dalla Corte stessa a ristoro dell’accertata violazione, si pone di regola a valle del giudicato, ciò che può imporne la cessazione degli effetti, la modifica o la rimozione. Nella pressoché totale inerzia del legislatore, la “via italiana” all’individuazione di un rimedio post-iudicatum in adeguamento ai canoni convenzionali si è rivelata assai tortuosa, passando prima per soluzioni meramente “pretorie”, poi per l’intervento additivo con cui la Corte costituzionale ha introdotto la revisione “europea”, peraltro inidonea ad offrire copertura esaustiva, a fronte dell’eterogeneità delle violazioni convenzionali e delle relative prescrizioni riparatorie. Di qui, per effetto ancora dell’“azione combinata” della giurisprudenza ordinaria e costituzionale, strade ulteriori sono state percorse, in particolare attraverso una lettura estensiva – se non analogica – dei poteri attribuiti dalla legge al giudice dell’esecuzione. Ciò, anche nell’ambito di una controversa tendenza “soggettivamente espansiva” dell’obbligo esecutivo ex art. 46 CEDU, volta ad estendere la caducazione del giudicato a soggetti diversi dal ricorrente a Strasburgo, che versino in condizioni analoghe al primo. In un siffatto contesto, il libro si propone, anzitutto, di ricostruire i presupposti, l’ambito applicativo e le difficoltà operative della revisione “europea” e di alcuni strumenti “limitrofi” di caducazione del giudicato “convenzionalmente illegittimo”, nell’intento di ricondurre a sistema uno stato dell’arte che sconta l’handicap della propria matrice giurisprudenziale. Allo stesso tempo, in un momento storico che non registra nuove iniziative legislative in materia, lo studio intende fornire qualche spunto de iure condendo, nell’auspicio di rialimentare un dibattito che sarebbe riduttivo ritenere definitivamente superato dalla supplenza giurisprudenziale.