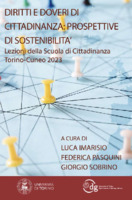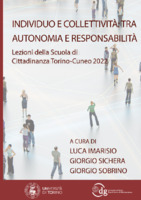Sfoglia documenti (3 in totale)
Sort by:
Diritti e doveri di cittadinanza tra Italia ed Europa
Questa pubblicazione costituisce ormai la quinta “traccia scritta” di un percorso condiviso di riflessione sui diritti e i doveri di cittadinanza, elaborato a partire dalle lezioni della Scuola di Cittadinanza, iniziativa di terza missione organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, nelle sedi di Torino e di Cuneo, a partire invece dal 2018.
Nell’edizione 2024 della Scuola di Cittadinanza le lezioni si sono tenute nei mesi immediatamente precedenti lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo. Ciò ha costituito l’occasione e lo stimolo per una riflessione interdisciplinare sulla varietà e complessità delle interazioni che legano l’ordinamento italiano a quello dell’Unione Europea (anche) nel riconoscimento e nella tutela dei diritti e dei doveri di cittadinanza, pure alla luce dell’emersione di nuove e rinnovate dimensioni di tale “sistema” di diritti e doveri.
Oltre a sviluppare riflessioni sul complessivo rapporto e sul “dialogo” esistente tra i due ordinamenti normativi, si è cercato di evidenziare le loro interdipendenze in ambiti divenuti oggi essenziali quali quello della disciplina (e del connesso tentativo di “governare” attraverso il diritto) l’intelligenza artificiale e i processi di digitalizzazione; quello della gestione dei fenomeni migratori (con un focus sul diritto penale); quello della gestione dell’impresa e delle sue risorse umane (con un’attenzione particolare rivolta alle recenti novità normative nel diritto dell’Unione Europea sulla sostenibilità e responsabilità sociale delle imprese). Un’attenzione specifica è stata dedicata al profilo dei diritti sociali –tradizionalmente oggetto di interventi più limitati da parte dell’ordinamento dell’Unione Europea –, sviluppando riflessioni inerenti alle questioni del salario minimo e a quelle connesse alla tutela del diritto alla salute. Così come ci si è soffermati sul problema (a sua volta strettamente legato ai diritti e doveri di cittadinanza) della convivenza tra le diverse credenze e confessioni religiose, tra il contesto italiano e quello, più generale, europeo.
L’obiettivo generale di questo percorso, non potendo certo essere quello di una organica ricostruzione del quadro dei rapporti tra l’ordinamento italiano e quello dell’Unione Europea in una materia oggi assai vasta e multiforme quale quella della configurazione dei diritti e doveri di cittadinanza, è stato piuttosto quello di far emergere – al di là di un approccio del dibattito pubblico spesso, alternativamente, retorico o polemico al tema dei “vincoli europei” –, l’esigenza di acquisire consapevolezza di dinamiche complesse, non sempre facilmente percepite, eppure destinate, nel contesto geografico in cui viviamo, ad avere ricadute sempre più estese sull’esercizio dei diritti e dei doveri individuali. Tutto ciò mirando a fornire, più che “risposte” univoche e definitive, stimoli al confronto e strumenti per interpretare e comprendere dal punto di vista del diritto questioni oggi fondamentali e, appunto, complesse come quelle trattate.
Diritti e doveri di cittadinanza: prospettive di sostenibilità
Questa pubblicazione rappresenta ormai la quarta tappa di un percorso di riflessione sui diritti e i doveri di cittadinanza, elaborato a partire dalle lezioni della Scuola di Cittadinanza, iniziativa di terza missione organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, nelle sedi di Torino e di Cuneo, a partire dal 2018.
Nell’edizione 2023 della Scuola si è proposto un itinerario di riflessione che, a partire da un inquadramento “di contesto” – il mondo globalizzato e la sua crisi, la complessità dei processi decisionali tra Italia e Unione Europea –, ha esplorato, da prospettive differenti, le implicazioni del principio di “sostenibilità” sui diritti e doveri fondamentali. Ci si è così confrontati coi temi della tenuta dei diritti fondamentali di fronte al dramma della guerra, delle potenzialità e dei limiti dell’impiego degli strumenti del diritto penale in relazione alla sostenibilità ambientale, della sostenibilità delle politiche di contrasto alla fragilità (che chiamano fortemente in causa i rapporti intergenerazionali), della gestione sostenibile delle diversità legate ai convincimenti etico-religiosi.
Con riguardo alla dimensione economica del principio di sostenibilità, si sono poi proposte riflessioni sul principio di sostenibilità intergenerazionale in relazione alle politiche tributarie e di bilancio, così come sulle implicazioni dei principi di sostenibilità e responsabilità nell’impresa e nel contesto lavorativo. Ci si è infine soffermati sul problema della sostenibilità del nostro stesso “modello” di democrazia (anche in relazione ai delicati rapporti tra decisione politica e controllo giurisdizionale), confrontandoci anche con le suggestioni e gli stimoli di “modelli” alternativi, ma animati a loro volta da obiettivi di solidarietà e responsabilità intergenerazionale, come quello legato alla proposta di una “Costituzione per la Terra” di Luigi Ferrajoli.
L’intento complessivo del Volume – pur nell'oggettiva impossibilità di esaurire un tema così controverso ed intricato quale quello delle diverse declinazioni del paradigma della sostenibilità, con riguardo ai diritti e doveri fondamentali – è far emergere, al di là dell’uso divenuto ormai tanto pervasivo quanto sfuggente ed ambiguo dei richiami a tale principio, una rete di implicazioni che, su diversi piani e a partire da diverse prospettive, incidono in misura determinante sul riconoscimento e sulla tutela delle libertà e dei diritti individuali, e rimodulano i correlativi doveri. Con l’ambizione (che anima la Scuola fin dal suo avvio) di proporre riflessioni che, partendo da elementi emergenti nell’attualità del confronto pubblico a livello nazionale e sovranazionale, consentano di fornire stimoli e di contribuire ad arricchire gli strumenti con cui maturare un giudizio più articolato e consapevole in ordine alle principali “questioni” connesse ai diritti e doveri di cittadinanza.
Individuo e collettività: tra autonomia e responsabilità
Questa pubblicazione rappresenta la terza tappa di un percorso di riflessione sui diritti e i doveri di cittadinanza, elaborato a partire dalle lezioni della Scuola di Cittadinanza, iniziativa di terza missione organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, nelle sedi di Torino e Cuneo, a partire dal 2018.
A differenza delle due precedenti edizioni delle Lezioni della Scuola, inevitabilmente segnate dall’esigenza del confronto con la situazione di emergenza legata alla pandemia Covid-19, l’edizione del 2022 è stata immaginata come l’occasione per un ritorno alla “fisiologia” del dibattito pubblico in tema di diritti e doveri di cittadinanza: un confronto “fuori dall’emergenza”, dedicato al problematico rapporto tra individuo e collettività, alla luce dei principi di autonomia e responsabilità, declinato in relazione a diversi profili legati appunto ai diritti e ai doveri fondamentali. Dal problema dell’esposizione dei simboli religiosi nelle scuole a quello del rapporto tra individui e collettività nelle istituzioni politiche rappresentative; alla questione dei doveri di solidarietà in materia fiscale; a quella dei presupposti di politica del diritto alla base delle scelte in materia di responsabilità penale, nella dialettica tra liberalismo e “paternalismo”; ad una riflessione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riferimento ai profili della digitalizzazione e della transizione ecologica; alla tematica dei fattori ESG in relazione alla responsabilità sociale e ambientale delle imprese; a quella degli equilibri tra solidarietà sociale e libertà individuale in riferimento agli obblighi vaccinali. Quanto agli aspetti più strettamente legati al mondo dell’istruzione (sempre oggetto di particolare attenzione nella Scuola di Cittadinanza), si propone una riflessione sulle “soft skills” nei percorsi formativi scolastici e sul tema delle competenze relazionali, nonché sul recente inserimento tra i principi fondamentali della Costituzione dell’”interesse delle generazioni future” e sulle sue ricadute sull’istruzione scolastica.
Nell’ultima parte del Volume sono poi raccolti gli interventi di una tavola rotonda conclusiva sul tema del ritorno della guerra in Europa, con particolare riferimento alle “sfide” ed alle responsabilità connesse per il mondo dell’istruzione e della comunicazione, che la Scuola ha ritenuto necessario organizzare a seguito dello scoppio del conflitto russo-ucraino. Il filo conduttore di tali interventi (e l’obiettivo della stessa tavola rotonda) consiste nel richiamo alla necessità di mantenere un approccio di riflessione critica ed aperta – anche in un contesto in cui la drammaticità delle condizioni impone la nettezza delle posizioni e delle attribuzioni di responsabilità –, nella convinzione che la repulsione rispetto all’idea per cui possa essere la guerra a tornare a ridefinire i confini dell’Europa debba essere anche repulsione rispetto all’idea per cui la guerra stessa possa arrivare a ridefinire i nostri “confini etici”.