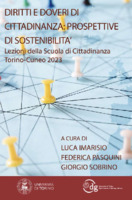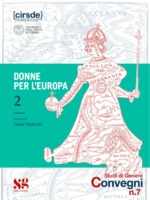Sfoglia documenti (231 in totale)
Sort by:
Dieci anni di REMS Un’analisi interdisciplinare
Il volume trae spunto dall’analisi dell’impatto della L. 81/2014 per proporre una riflessione più ampia sull’attuale configurazione del sistema delle misure di sicurezza personali. Come noto, la riforma del 2014 ha previsto – fra le altre misure – la definitiva chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari a favore di un articolato sistema territoriale che vede nell’internamento del reo non imputabile, o con imputabilità diminuita, all’interno delle nuove Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) l’extrema ratio, laddove la pericolosità sociale dell’autore del reato non consenta l’applicazione di una misura non custodiale. In una prospettiva multidisciplinare, il volume, articolato in quattro sezioni, affronta le diverse questioni che hanno accompagnato l’entrata in vigore e l’applicazione della riforma. Nella prima (le persone) sono analizzate le caratteristiche principali dei soggetti che transitano all’interno del sistema delle misure di sicurezza penali, ed in particolare delle REMS. Nella seconda sezione (i luoghi) è affrontata la materiale organizzazione delle REMS in rapporto agli obiettivi di cura che tale istituzione si prefigge. Nella terza parte (i percorsi), l’analisi si sposta sul terreno dei tragitti – formalmente previsti e concretamente attuati – nell’ambito del sistema delle misure di sicurezza. La quarta e ultima sezione (i contesti) muove lo sguardo oltreconfine adottando una dimensione comparatista. In questo caso, la riflessione si spinge a riflettere sul quadro sovranazionale del rapporto tra esigenze di difesa sociale e tutela dei diritti fondamentali dei soggetti psichiatrici autori di reato per approfondire l’indagine sul terreno delle norme e pratiche europee in materia di sorveglianza e cura del «folle reo».
Digitalizzazione e PMI Mappatura del processo di digitalizzazione delle imprese piemontesi (primo rapporto)
Nell'estate del 2019 il «Centro Luigi Bobbio» dell'Università di Torino ha svolto un'indagine sulle rappresentazioni sociali dello sviluppo, intervistando un ampio campione rappresentativo di 2.000 cittadini piemontesi e 2.000 italiani, e un campione a “scelta ragionata” di 169 testimoni qualificati del Piemonte, selezionati a livello regionale e provinciale tra i rappresentanti del mondo associativo, politico e istituzionale. La ricerca, realizzata prima dell'esplosione dell'emergenza Covid-19, restituiva uno sguardo molto preoccupato sul futuro della regione e del nostro paese. Una sensazione di declino che, seppure non inevitabile, veniva percepita come altamente probabile. Proiettandosi in un orizzonte temporale di dieci anni, la maggioranza relativa degli intervistati immaginava una situazione sociale ed economica peggiore rispetto a quella allora presente. Il pessimismo, in particolare, prevaleva tra i giovani, i ceti popolari e i lavoratori autonomi.
L'indagine, realizzata dall'istituto Demetra, è stata ripetuta tra il 7 giugno e l'8 agosto 2021, in collaborazione con Noovle, una società del gruppo Telecom, intervistando un campione rappresentativo di 1.000 cittadini piemontesi e 1.000 italiani e un campione a scelta ragionata di 161 testimoni qualificati del Piemonte. I risultati mostrano che la pandemia ha cambiato radicalmente lo scenario, rilanciando l'ottimismo. Quest'ultimo denota un atteggiamento positivo verso il futuro, che induce a ritenere più probabile il verificarsi di avvenimenti favorevoli piuttosto che il contrario. Si tratta perciò di un modo particolare di guardare al domani, anticipando delle previsioni positive. Ciò che possiamo dire oggi è che il futuro immaginato dai piemontesi e dagli italiani per il prossimo decennio è più favorevole di quanto non lo fosse prima della pandemia.
Diritti e doveri di cittadinanza tra Italia ed Europa
Questa pubblicazione costituisce ormai la quinta “traccia scritta” di un percorso condiviso di riflessione sui diritti e i doveri di cittadinanza, elaborato a partire dalle lezioni della Scuola di Cittadinanza, iniziativa di terza missione organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, nelle sedi di Torino e di Cuneo, a partire invece dal 2018.
Nell’edizione 2024 della Scuola di Cittadinanza le lezioni si sono tenute nei mesi immediatamente precedenti lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo. Ciò ha costituito l’occasione e lo stimolo per una riflessione interdisciplinare sulla varietà e complessità delle interazioni che legano l’ordinamento italiano a quello dell’Unione Europea (anche) nel riconoscimento e nella tutela dei diritti e dei doveri di cittadinanza, pure alla luce dell’emersione di nuove e rinnovate dimensioni di tale “sistema” di diritti e doveri.
Oltre a sviluppare riflessioni sul complessivo rapporto e sul “dialogo” esistente tra i due ordinamenti normativi, si è cercato di evidenziare le loro interdipendenze in ambiti divenuti oggi essenziali quali quello della disciplina (e del connesso tentativo di “governare” attraverso il diritto) l’intelligenza artificiale e i processi di digitalizzazione; quello della gestione dei fenomeni migratori (con un focus sul diritto penale); quello della gestione dell’impresa e delle sue risorse umane (con un’attenzione particolare rivolta alle recenti novità normative nel diritto dell’Unione Europea sulla sostenibilità e responsabilità sociale delle imprese). Un’attenzione specifica è stata dedicata al profilo dei diritti sociali –tradizionalmente oggetto di interventi più limitati da parte dell’ordinamento dell’Unione Europea –, sviluppando riflessioni inerenti alle questioni del salario minimo e a quelle connesse alla tutela del diritto alla salute. Così come ci si è soffermati sul problema (a sua volta strettamente legato ai diritti e doveri di cittadinanza) della convivenza tra le diverse credenze e confessioni religiose, tra il contesto italiano e quello, più generale, europeo.
L’obiettivo generale di questo percorso, non potendo certo essere quello di una organica ricostruzione del quadro dei rapporti tra l’ordinamento italiano e quello dell’Unione Europea in una materia oggi assai vasta e multiforme quale quella della configurazione dei diritti e doveri di cittadinanza, è stato piuttosto quello di far emergere – al di là di un approccio del dibattito pubblico spesso, alternativamente, retorico o polemico al tema dei “vincoli europei” –, l’esigenza di acquisire consapevolezza di dinamiche complesse, non sempre facilmente percepite, eppure destinate, nel contesto geografico in cui viviamo, ad avere ricadute sempre più estese sull’esercizio dei diritti e dei doveri individuali. Tutto ciò mirando a fornire, più che “risposte” univoche e definitive, stimoli al confronto e strumenti per interpretare e comprendere dal punto di vista del diritto questioni oggi fondamentali e, appunto, complesse come quelle trattate.
Diritti e doveri di cittadinanza: prospettive di sostenibilità
Questa pubblicazione rappresenta ormai la quarta tappa di un percorso di riflessione sui diritti e i doveri di cittadinanza, elaborato a partire dalle lezioni della Scuola di Cittadinanza, iniziativa di terza missione organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, nelle sedi di Torino e di Cuneo, a partire dal 2018.
Nell’edizione 2023 della Scuola si è proposto un itinerario di riflessione che, a partire da un inquadramento “di contesto” – il mondo globalizzato e la sua crisi, la complessità dei processi decisionali tra Italia e Unione Europea –, ha esplorato, da prospettive differenti, le implicazioni del principio di “sostenibilità” sui diritti e doveri fondamentali. Ci si è così confrontati coi temi della tenuta dei diritti fondamentali di fronte al dramma della guerra, delle potenzialità e dei limiti dell’impiego degli strumenti del diritto penale in relazione alla sostenibilità ambientale, della sostenibilità delle politiche di contrasto alla fragilità (che chiamano fortemente in causa i rapporti intergenerazionali), della gestione sostenibile delle diversità legate ai convincimenti etico-religiosi.
Con riguardo alla dimensione economica del principio di sostenibilità, si sono poi proposte riflessioni sul principio di sostenibilità intergenerazionale in relazione alle politiche tributarie e di bilancio, così come sulle implicazioni dei principi di sostenibilità e responsabilità nell’impresa e nel contesto lavorativo. Ci si è infine soffermati sul problema della sostenibilità del nostro stesso “modello” di democrazia (anche in relazione ai delicati rapporti tra decisione politica e controllo giurisdizionale), confrontandoci anche con le suggestioni e gli stimoli di “modelli” alternativi, ma animati a loro volta da obiettivi di solidarietà e responsabilità intergenerazionale, come quello legato alla proposta di una “Costituzione per la Terra” di Luigi Ferrajoli.
L’intento complessivo del Volume – pur nell'oggettiva impossibilità di esaurire un tema così controverso ed intricato quale quello delle diverse declinazioni del paradigma della sostenibilità, con riguardo ai diritti e doveri fondamentali – è far emergere, al di là dell’uso divenuto ormai tanto pervasivo quanto sfuggente ed ambiguo dei richiami a tale principio, una rete di implicazioni che, su diversi piani e a partire da diverse prospettive, incidono in misura determinante sul riconoscimento e sulla tutela delle libertà e dei diritti individuali, e rimodulano i correlativi doveri. Con l’ambizione (che anima la Scuola fin dal suo avvio) di proporre riflessioni che, partendo da elementi emergenti nell’attualità del confronto pubblico a livello nazionale e sovranazionale, consentano di fornire stimoli e di contribuire ad arricchire gli strumenti con cui maturare un giudizio più articolato e consapevole in ordine alle principali “questioni” connesse ai diritti e doveri di cittadinanza.
Diritti e doveri oltre l'emergenza? Dalla pandemia Covid-19 verso nuovi modelli di convivenza
Questa pubblicazione rappresenta la seconda tappa di un percorso avviato lo scorso anno, con l’intento di elaborare, a partire dalle lezioni svolte nel contesto della Scuola di Cittadinanza Torino – Cuneo organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, una riflessione sui diritti e i doveri di cittadinanza nel tempo presente.
L’edizione di quest’anno è maturata in un contesto (reale, ed anche politico e mediatico) nel quale l’emergenza derivante dalla pandemia Covid-19, pure sempre presente e centrale, è risultata in qualche modo per lo meno prevista, messa in conto. E maggiormente “gestita”, pur tra tensioni e contraddizioni, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista delle regole del vivere civile. Con la prospettiva di un processo che conduca, auspicabilmente, “oltre l’emergenza”.
Sulla base di questa cifra del tempo presente che ci è parso di cogliere e che abbiamo provato ad interpretare, l’edizione della Scuola di Cittadinanza di quest’anno, nella volontà di dare una continuità ma anche uno sviluppo alle riflessioni dello scorso anno, si è soprattutto interrogata sui riflessi – su una varietà di ambiti comunque connessi a diritti e doveri fondamentali – di questa fase di lunga, incompiuta, a volte controversa fuoriuscita dall’emergenza.
Alla seconda parte del presente Volume, che raccoglie i contributi elaborati a partire dalle lezioni della Scuola tenute nell’anno 2021, si è scelto di anteporre una prima parte destinata, da un lato, ad approfondire il tema dell’insegnamento dell’educazione civica nella scuola primaria e secondaria (tema centrale nella prospettiva della Scuola di Cittadinanza e del dialogo auspicato tra Università e scuola sul tema dei diritti e dei doveri fondamentali), e dall’altra parte a valorizzare i contributi di giovani studiosi che, con ruoli diversi e in fasi diverse del loro percorso, si sono confrontati con il mondo della ricerca universitaria, in uno spirito complessivo di dialogo tra punti di vista, esperienze e persino linguaggi diversi.
Donne "da favola". Evoluzioni e contraddizioni dello stereotipo femminile nel racconto fantastico
How has the image of the woman changed over time? Can we say that certain "old" stereotypes have lapsed?
In this analysis I’ve reflected about the theme, comparing some modern cinematographic revisitations and the corresponding written texts in the field of the fantastic genre, to understand if and how the female image (and not only) has changed from a century to another (in this case between the 19th and the 21st century).
The research has developed through the semiotic and gender studies, in order to analyze the diversities and the characteristics of the various texts observed (written and audiovisual) and to realize how the idea of feminine is changed and, maybe, evolved, proposing new type of characters (and also a new and complex dialogue with the masculine counterpart).
It emerges, indeed, the necessity to reflect on these stereotypes, on the modalities of development over time and on the difficulty that still today, despite certain changes, remains in thinking them (and thinking differently).
Because, in the end, what does it mean male and female? What makes us who we are?
Donne per l'Europa 1
Nel 2007, in occasione dell’Anno Europeo delle Pari Opportunità, il CIRSDe promosse, con l’appoggio della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, l’istituzione delle Giornate annuali «Donne per l’Europa», titolo che riprende il nome del gruppo «Femmes pour l’Europe», fondato da Ursula Hirschmann negli anni 1970. L’intento era – ed è rimasto – quello di invitare annualmente una/o studiosa/o di respiro internazionale a tenere una Lezione sul tema, e un gruppo di altre/i partecipanti a riflettere sul contributo diretto delle donne a pensare, costruire e immaginare l’Europa.
Questo libro è una riedizione di Donne per l’Europa (Rosenberg & Sellier, 2013) e raccoglie gli atti delle prime quattro giornate per Ursula Hirschmann, organizzate nel 2007, 2008, 2009 e 2012, oltre a una serie di altri contributi di studiose che hanno dedicato i loro recenti studi a questa figura femminile.
Donne per l'Europa 2
La pubblicazione di questo secondo volume di Donne per l’Europa e la contemporanea riedizione del primo volume (del 2013) consentono di evidenziare un itinerario di pensiero e discussione lungo la strada indicata da Ursula Hirschmann e dal gruppo da lei fondato nel 1975 a Bruxelles. “Femmes pour l’Europe” si prefiggeva lo scopo di portare avanti l’ispirazione del Manifesto di Ventotene del 1941 per un’Europa intesa come patria di giustizia e uguaglianza, aprendola alla prospettiva di genere.
Questo volume, che raccoglie gli atti delle giornate per Ursula Hirschmann organizzate dal 2013 al 2017, è completato dalla Lectio Magistralis tenuta da Rosi Braidotti all’Istituto Europeo di Firenze nel 2001, una riflessione su genere, identità e multiculturalismo in Europa.
Donne per l’Europa. Atti delle prime tre giornate per Ursula Hirschmann
Nel 2007, in occasione dell’Anno Europeo delle Pari Opportunità, il CIRSDe promosse, con l’appoggio della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, l’istituzione delle Giornate annuali «Donne per l’Europa», titolo che riprende il nome del gruppo «Femmes pour l’Europe», fondato da Ursula Hirschmann negli anni 1970. L’intento era – ed è rimasto – quello di invitare annualmente una/o studiosa/o di respiro internazionale a tenere una Lezione sul tema, e un gruppo di altre/i partecipanti a riflettere sul contributo diretto delle donne a pensare, costruire e immaginare l’Europa.
In questo libro raccogliamo gli atti delle prime tre giornate per Ursula Hirschmann, organizzate nel 2007, 2008 e 2009, oltre a una serie di altri contributi di studiose che hanno dedicato i loro recenti studi a questa figura femminile.