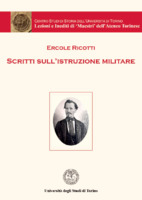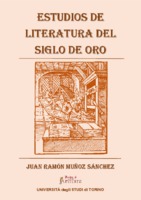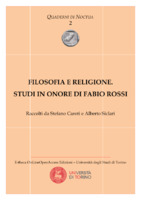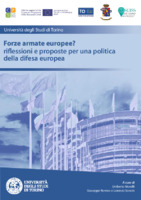Sfoglia documenti (233 in totale)
Sort by:
Donne per l’Europa. Atti delle prime tre giornate per Ursula Hirschmann
Nel 2007, in occasione dell’Anno Europeo delle Pari Opportunità, il CIRSDe promosse, con l’appoggio della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, l’istituzione delle Giornate annuali «Donne per l’Europa», titolo che riprende il nome del gruppo «Femmes pour l’Europe», fondato da Ursula Hirschmann negli anni 1970. L’intento era – ed è rimasto – quello di invitare annualmente una/o studiosa/o di respiro internazionale a tenere una Lezione sul tema, e un gruppo di altre/i partecipanti a riflettere sul contributo diretto delle donne a pensare, costruire e immaginare l’Europa.
In questo libro raccogliamo gli atti delle prime tre giornate per Ursula Hirschmann, organizzate nel 2007, 2008 e 2009, oltre a una serie di altri contributi di studiose che hanno dedicato i loro recenti studi a questa figura femminile.
Edge AI in nature: insect-inspired neuromorphic Reflex Islands for safety-critical edge systems
Insects achieve millisecond sensor–motor loops with tiny sensors, compact neural circuits, and powerful actuators, embodying the principles of Edge AI [1–9]. We present a comprehensive architectural blueprint translating insect neurobiology into a hardware–software stack: a latency-first control hierarchy that partitions tasks between a fast, dedicated Reflex Tier and a slower, robust Policy Tier, with explicit WCET envelopes and freedom-from- interference boundaries [1–9]. This architecture is realized through a neuromorphic Reflex Island utilizing spintronic primitives, specifically MRAM synapses (for non-volatile, innate memory) and spin-torque nano-oscillator (STNO) reservoirs (for temporal processing), to enable instant-on, memory-centric reflexes [10–16]. Furthermore, we formalize the biological governance mechanisms, demonstrating that unlike conventional ICEs and miniturbines that exhibit narrow best-efficiency islands, insects utilize active thermoregulation and DGC (Discontinuous Gas Exchange) to maintain nearly constant energy efficiency across a broad operational load by actively managing their thermal set-point, which we map into thermal-debt and burst-budget controllers [17–33]. We instantiate this integrated bio-inspired model in an insect-like IFEVS thruster, a solar cargo e-bike with a neuromorphic safety shell, and other safety-critical edge systems, providing concrete efficiency comparisons, latency and energy budgets, and safety-case hooks that support certification and adoption across autonomous domains [6,11,14,28].
Ercole Ricotti. Scritti sull’istruzione militare
Gli scritti sull’istruzione militare, qui presentati, risalgono a una stagione particolare della vita di Ercole Ricotti, che dal 1840 al 1855 si dedicò allo studio di questioni di storia e di istruzione militari con l’obiettivo di migliorare la formazione della truppa e degli ufficiali. Questo corpus di testi venne redatto tra il 1845 e il 1856 in un contesto caratterizzato da ampie riforme nel campo dell’Istruzione pubblica e in un clima politico segnato dalla sconfitta delle truppe piemontesi nella prima guerra d’indipendenza nel 1848-1849.
Estudios de literatura del Siglo de Oro
En Estudios de literatura del Siglo de Oro se reúne una colectánea de ocho trabajos de naturaleza dispar escrita y, en su mayoría, publicada a lo largo del último decenio. No obstante su heterogeneidad y variedad, el volumen tiene el denominador común tanto del género, el artículo académico o la “monografía breve” –aunque haya alguna que, por no avenirse bien con el precepto de la concisión, parezca sobrarle el adjetivo–, como el tema, la literatura española de los siglos XVI y XVII enfocada desde diversos ángulos, que se señalan en los cuatro apartados en que se dispone.
Euro-American Relations in the Age of Globalization: Risks and Opportunities
The special issue of De Europa on “Euro-American Relations in the Age of Globalization: Risks and Opportunities” includes multi-disciplinary approaches to the current Euro-American relations, with a focus on the new scenarios created by the Trump administration as well as at the crises and transformations in transatlantic relations during the three decades between 1989 and 2019.
Famiglie transfrontaliere: regimi patrimoniali e successori
L'opera raccoglie gli atti di un Convegno tenutosi l'8 novembre 2019 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, dedicato all'impatto per le famiglie transfrontaliere dell'entrata in vigore dei Regolamenti UE n. 1103 e 1104 del 2016 rispettivamente in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e del Regolamento UE n. 650 del 2012 sulle successioni internazionali.
Family Reunification in EU Law Essential text, cases and materials
The book is an introduction to the key features of family reunification in EU law. The first part is devoted to family reunification of EU citizens, pursuant to Directive 2004/38/EC. The second section addresses Directive 2003/109/EC on family reunification of Third Country Nationals. The book collects and systematizes excerpts from legal texts and judgments of the Court of Justice of the European Union interpreting them. As such, it is mainly intended for students and other readers willing to deepen their knowledge about this topic. The formatting of the book complies with the most reputed indications on readability for persons with specific learning disabilities.
Fenomeni migratori, famiglie cross border e questioni di diritto successorio. Una prospettiva di genere
L’opera raccoglie i testi delle relazioni svolte nel corso del Convegno, da cui il volume stesso prende il nome, tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino l’11 aprile 2024, e che ha visto confrontarsi numerosi studiosi e studiose, appartenenti a diversi settori scientifico-disciplinari, su un tema di grande attualità, quale è la rilevanza giuridica dei fenomeni migratori negli ordinamenti nazionali.
Filosofia e religione. Studi in onore di Fabio Rossi
I 14 saggi raccolti in questo volume esplorano i rapporti fra filosofia e religione fra età antica e contemporanea, e lo sviluppo della filosofia della religione a partire dall’età moderna: soffermandosi da una parte sui problemi dell’ateismo, della natura del Cristo, e della teologia razionale di matrice cartesiana, e dall’altra sulle ramificazioni contemporanee della filosofia della religione: nell’ermeneutica, la fenomenologia, e il materialismo storico.
The 14 essays in this volume explore the relationship between philosophy and religion from antiquity to the contemporary age, as well as the development of a philosophy of religion in modern times. It does so by focusing on the topics of atheism, the nature of Christ, and the Cartesian origins of rational theology, on the one hand, and on the contemporary ramifications of philosophy of religion: in hermeneutics, phenomenology, and historical materialism, on the other.
The 14 essays in this volume explore the relationship between philosophy and religion from antiquity to the contemporary age, as well as the development of a philosophy of religion in modern times. It does so by focusing on the topics of atheism, the nature of Christ, and the Cartesian origins of rational theology, on the one hand, and on the contemporary ramifications of philosophy of religion: in hermeneutics, phenomenology, and historical materialism, on the other.
Forze armate europee? Riflessioni e proposte per una politica della difesa europea
Il 15 maggio 2019 si tenne una giornata di studio presso il Comando per la Formazione e Scuola d’Applicazione dell’Esercito organizzata dalla Scuola stessa e dalla Cattedra Jean Monnet attivata presso il Dipartimento Culture, Politica e Società dell’Università di Torino. Alcune delle relazioni presentate al convegno, insieme a contributi successivi, vengono pubblicate in questo volume collettaneo per vari motivi. Il primo, e più importante, è la messa in circolazione delle idee esposte. Il dibattito sul tema, infatti, è di stringente attualità nel mondo contemporaneo, sempre più insicuro, anche se poco approfondito se non in sede accademica e fra gli addetti ai lavori. Questa pubblicazione ha l’obiettivo di indurre il lettore a riflettere sul problema della difesa europea, fornirgli spunti di riflessione e di critica (nel senso greco del termine, ovvero del giudicare) affinché possa elaborare una valutazione o, meglio ancora, una presa di posizione personale basata sui fatti qui esposti. Il fatto che si discuta di “esercito europeo” è già da solo una buona motivazione e un successo per i relatori e gli organizzatori del convegno. Poco importa che si sia favorevoli o contrari; ciò che conta è disporre di sufficienti informazioni per essere consapevoli del problema e delle sfide che l’Unione Europea deve affrontare.
Un altro motivo che ci ha condotti a questa pubblicazione è l’impegno e la dedizione dimostrata dai singoli relatori e dalle organizzazioni a vario titolo coinvolte nella riuscita dell’evento. Ad aprire la fila di queste è la Scuola d’Applicazione dell’Esercito, la quale nella figura del Generale Salvatore Cuoci conferma il suo interesse e la sua disponibilità al dibattito ed alla crescita del personale che tale istituzione è volta a formare.
L’Università degli Studi di Torino costituisce poi la seconda colonna portante del successo dell’evento. Attraverso la Cattedra Jean Monnet, di cui è titolare il prof. Umberto Morelli, ha favorito la partecipazione di illustri studiosi e fornito i mezzi materiali necessari alla buona riuscita della conferenza. Ai singoli relatori va rivolto un ringraziamento particolare per la competenza, la passione e la dedizione profusa.
Ci auguriamo, dunque, che il lettore trovi in queste pagine sia spunti di riflessione interessanti e stimolanti sia il piacere dell’approfondimento di un tema troppo ignorato dall’opinione pubblica.